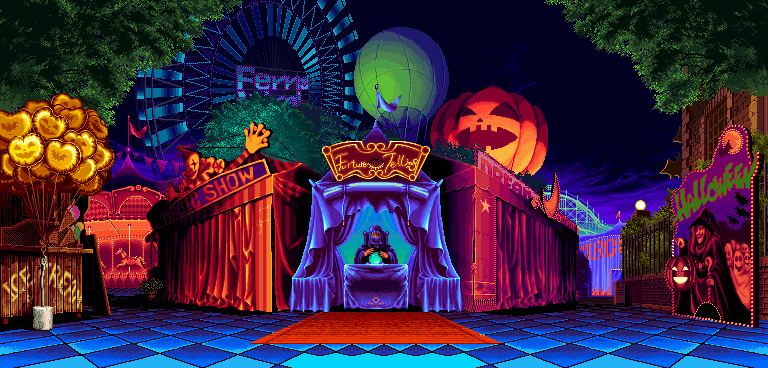Potrei iniziare questo articolo con una massima scontata ma mai banale, appropriata ma ormai inflazionata:
Il tempo è relativo.
È una regola universale che vale anche nel mondo videoludico .
Titoli intramontabili come Super Mario Bros. scindono da qualsiasi vincolo temporale, perché eterni, sempreverdi.
Quando trent’anni fa venne rilasciato il primo storico Super Mario Bros. su Famicom (da noi in occidente conosciuto come NES), probabilmente non si era consci di come, quel mondo costellato di pixel celasse la formula di un elisir dell’immortalità, un algoritmo semplicemente perfetto di un gioco capace di intrattener e divertire tuttora, per quanto intanto di progressi se ne sono fatti parecchi dall’era dell’8-bit.
Siamo nell’era del videorealismo, del 4K, dei 60 fps, di tutte quelle terminologie tecniche di cui ci si riempie la bocca ma che in sostanza a nulla servono. Sono standard che ormai si pretendono e si danno per scontati, in una costante ed estenuante ricerca della perfezione grafica, divenuta oramai monomania fine a se stessa.
Ciò che conta è il divertimento e un gioco, per quanto virtualmente possa offrire un quantitativo incalcolabile di intrattenimento, finisce quando giunge la noia e la ripetitività. Torniamo dunque al fattore temporale, facendo delle distinzioni.
Esiste longevità e temporalità.
La longevità è relativa alla durata effettiva di un gioco, di quanto esso offra intrattenimento al giocatore, spesso concludendosi con i titoli di coda dell’avventura principale.
La temporalità è un concetto più romantico ed astratto: è la vita effettiva di un gioco, relativa all’interesse del pubblico.
Super Mario Bros. lo si può concludere anche in un pomeriggio (longevità) ma il suo fattore temporale lo rende un gioco che, per quanto potrebbe risultare antologico e desueto, possiede un fattore temporale che lo eleva ad essere, per l’appunto, intramontabile.
È un classico, e vale così per ogni forma d’arte: che si tratti di Dostoevskij per la letteratura o di Hitchcock per il cinema, anche i videogiochi non sfuggono al concetto di classico.
Parlando dei tempi odierni, il concetto di temporalità è piuttosto effimero, per quanto paradossale possa sembrarlo.
Rispetto al passato, le pubblicazioni videoludiche sono costanti, con release divenute oramai giornaliere, anche grazie al mercato indipendente e al mondo digitale, laddove prima non esisteva questa possibilità.
I videogiochi odierni si incentrano sulla giocabilità online, funzionalità che ha sempre esteso la longevità di un titolo e conseguenzialmente anche la sua temporalità.
Il paradosso sta proprio in questo; per quanto il gioco in rete dovrebbe concedere virtualmente un quantitativo di ore tendenti all’infinito, con tutte le possibilità e le funzionalità che mette a disposizione dei giocatori, subentra un fattore umano: la noia.
L’utenza è certamente cambiata e di conseguenza il mondo videoludico, che ruota sempre più velocemente. I videogiocatori sanno stufarsi presto anche di un sistema di gioco che dovrebbe poterli intrattenere a lungo. Eppure, il pubblico esigente, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, pur di soddisfare le proprie, cangianti esigenze, va altrove.
Perché?
Siamo una generazione incontentabile che vanta una libreria di titoli nauseantemente estesa, con tutti i prodotti acquistati con sufficienza durante gli sconti digitali. Impulsi di oniomania che ci hanno condotto ad aver anche centinaia di titoli senza saperli gestire, lasciandoli lì e giocandoci “quando si avrà tempo”. Chissà quanti di quei prodotti, magari acquistati anche con coscienza e sincero interesse saranno poi portati a termine e considerati, non si sa quando.
I progetti a “lungo termine” di un gioco online sono spesso traditi dalla stessa utenza che richiede longevità sui giochi in cui va ad investire, tra il prezzo del titolo in questione e i season pass truffaldini del caso, che poi inesorabilmente non può e/o non vuole più dedicar tempo al suddetto progetto. L’esempio lampante è The Division, con tutto l’hype che trascinò con sé come si confà ad Ubisoft nel presentare le sue perle, prodotti commerciali preconfezionati e propinati all’utenza media che spende, la stessa che annualmente fa la fila al Gamestop per Assassin’s Creed in quella che reputo una sindrome di Stoccolma inconscia. Il titolo della società francese propone un sistema di gioco unicamente online, con il progressivo sblocco delle aree di una NY serragliata e talebana. I primi mesi mi sembrano furono piuttosto prolifici per il gioco con una utenza presente ed attiva. Poi il tracollo. Ubisoft sembrava ambisse ad un progetto che si estendesse sul piano temporale come è riuscito ad Activision con Destiny, ormai giunto al terzo anno, con un pubblico sorprendentemente fedele. Una fedeltà tradita e malriposta, per quanto in The Division l’utenza sia tuttora presente e certamente se lo acquistate – o se lo possedete già, accendete la console – , non troverete un mondo deserto. Però, potrete constatare come l’utenza sia ridotta drasticamente rispetto ai primi mesi di gioco. Sembra però che non basti questa disponibilità, laddove invece The Division mantiene le sue funzionalità in game. Ma al pubblico non va più come prima di mettercisi sù. Perché? Perché si intrattiene con altro, perché il concetto di temporalità, per quanto è stato considerato nei piani di Ubisoft, è sfuggito, s’è dissipato.
Un mondo infame, ma che continua a puntare insistentemente sul multiplayer dove forse l’utenza gradirebbe incentrarsi sull’esperienza in singolo che forse a molti manca.
Laddove prima la funzionalità online era un servizio aggiunto ad un titolo che offriva il single player, ora è il contrario: l’esperienza in singolo è messa in secondo piano rispetto al gioco in rete con gli altri giocatori.
Forse è bene che si inizi a tornare sui propri passi, riproponendo esperienze individuali ai videogiocatori di cui si sente l’assenza. Le esperienze di gioco in rete sono senz’altro esaltanti ma hanno generato una generazione di videogiocatori competitivi che talvolta non sembrano saper gestire una formula di intrattenimento e di sfida così ampio.
Il multiplayer online ha certamente cambiato il mondo del videogioco, permettendoci di realizzare quel sogno inizialmente concretizzato da Sega col Saturn, prima console casalinga ad usufruire del servizio in rete per poter giocare con altre persone in tutto il mondo. Ora lo si da per scontato, ma il grande passo venne fatto oramai 20 anni fa dalla società giapponese. Un servizio adoperato da pochi all’epoca (considerando soprattutto una comparazione con l’utenza odierna) certo, però fu l’inizio di un percorso che permise ai giocatori di tutto il mondo di condividere le proprie esperienze videoludiche. Un sogno che forse è stato coltivato da ogni sviluppatore del settore prima di oggi, prima di Sega. Oggi è la consuetudine, la prassi, il naturale concetto di videogioco instillato nell’immaginifico collettivo, anche ai “babbani” che non sono addentrati nel mondo dell’intrattenimento elettronico. Eppure, per quanto sia straordinario, sembra non si abbia considerato di come avere un’utenza sempre attiva e presente su ogni progetto che proponga un servizio online non è possibile seppur, sorprendentemente, si riescano ad incontrare giocatori anche su server dimenticati. A me sembra che si generino deserti, lasciati incustoditi dopo anni di attività, di come si tenti di mantenerli attivi per quella poca, fedele utenza. Mondi estesi ed esplorabili abbandonati o disabitati. E di come, inesorabilmente, anche i titoli a cui giochiamo oggi, prima o poi verranno lasciati al caso. Il processo avviene velocemente, considerando come alcuni giochi, per quanto non vengano abbandonati, abbiano una temporalità limitata, perché la tendenza richiama l’attenzione e l’interesse su altri prodotti.
Capita anche che, un gioco uscito lo scorso anno sia già considerato relativamente “vecchio“. Succede che si dimentica in fretta, in un mondo videoludico che ci tartassa di informazioni e che guarda sempre al futuro, lasciandoci smarrire il concetto di temporalità.